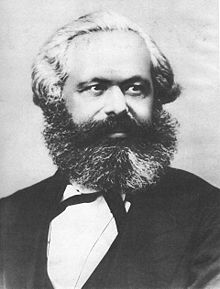La Seconda Internazionale fu fondata a Parigi nel 1889 e fu da subito lacerata dai contrasti tra radicali e revisionisti. Il congresso costitutivo fu dominato dai socialdemocratici tedeschi, all’epoca, il più forte partito proletario, che si divideva tra la corrente revisionista guidata da Eduard Bernstein (1850 – 1932) e quella ortodossa capitanata da Karl Kautsky (1854 – 1938). Importante sottolineare che aderirono alla Seconda Internazionale i nuovi partiti socialisti, che si stavano costituendo, ad esempio, il Partito Socialista italiano del 1892 e il partito Laburista inglese del 1893. Il programma di massima, per tutte le componenti, fu quello marxista della conquista del potere finalizzata all’ instaurazioni di una società socialista, senza, però, escludere l’azione volta al raggiungimento di graduali riforme misurate secondo i criteri dell’opportunità e della possibilità. Nonostante tale approccio, in sostanza, però, convivevano nello stesso corpo due anime inconciliabili: quella rivoluzionaria e quella riformista ed esse confluivano sia nell’ambito dei diversi partiti che dei diversi militanti. Comunque sulla linea rivoluzionaria, che appunto prevedeva come metodo dell’acquisizione del potere la lotta di classe armata, prese il sopravvento, quella cosiddetta legalitaria, cioè attraverso le istituzioni e le regole parlamentari, e sempre più si acuì la distinzione tra meta finale, ossia l’eliminazione dello stato borghese, e le riforme graduali di struttura, tanto che cominciò a ritenersi possibile la collaborazione con le forze progressiste della borghesia. Il programma, formulato ad Erfurt nel 1891 dalla SPD(?) (socialdemocrazia tedesca), ispirò tutta l’opera della Seconda Internazionale. Gli obiettivi rivoluzionari furono proiettati in un futuro lontano e passarono, di contro, in primo piano una serie di mete da raggiungersi nell’immediato, tra queste: il suffragio universale, il sistema elettorale proporzionale, l’istituzione di un esercito popolare al posto di quello professionale, l’abrogazione delle leggi restrittive della libertà personale, la parità della donna rispetto all’uomo, la dichiarazione del carattere privato di tutte le religioni, l’assistenza medica gratuita, la giornata lavorativa di otto ore e la gestione pubblica delle assicurazioni sociali per l’invalidità, la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro. La Seconda Internazionale crollò sotto i colpi della Grande Guerra; infatti, nonostante si fosse decretata l’intransigente opposizione alla guerra, durante il congresso di Stoccarda del 1907; nel 1914, quando scoppiò la guerra, l’organizzazione si frantumò, poiché i singoli partiti socialisti aderirono alla politica dei loro governi nazionali. A questo punto la rottura tra i rivoluzionari di Lenin e Rosa Luxemburg e i socialisti patrioti divenne insanabile. La corrente rivoluzionaria, dopo la guerra (ma soprattutto dopo la rivoluzione d’Ottobre), nel 1919, diede vita alla Prima Internazionale Comunista (o Terza Internazionale) mentre a Vienna i socialisti tedeschi, svizzeri e austriaci danno vita all’Unione Internazionale Socialista. Infine, solo nel 1951 con il Congresso di Francoforte sul Meno, è stata costituita l’Internazionale Socialista. La socialdemocrazia tedesca Ad oggi, con il termine socialdemocrazia si è soliti designare quei movimenti socialisti che intendono muoversi rigorosamente ed esclusivamente nell’ambito delle istituzioni liberaldemocratiche e accettano, senza riserve ma entro certi limiti, la funzione insostituibile del mercato e della proprietà privata. In realtà le cose non sono state sempre in questi termini. I socialdemocratici, fondatori della Seconda Internazionale, non ritenevano, affatto di essere dei riformisti, anzi, rivendicavano con fierezza la loro propensione rivoluzionaria. «La socialdemocrazia – ammoniva Kautsky, soprannominato il Papa rosso – è un partito rivoluzionario, non un partito che fa le rivoluzioni. Noi sappiamo che il nostro fine può essere raggiunto soltanto per mezzo di una rivoluzione, ma sappiamo che è altrettanto poco in nostro potere fare questa rivoluzione, quanto è in potere dei nostri avversari di impedirlo. Perciò noi non pensiamo affatto a provocare o a preparare una rivoluzione. E poiché noi non possiamo fare la rivoluzione a nostro arbitrio, non possiamo dire alcunché a proposito di quando, in quali circostanze e in quali forme la rivoluzione avrà luogo. Noi sappiamo che la lotta di classe fra borghesia e proletariato non terminerà fino a quando quest’ultimo non arriverà al pieno possesso del potere politico, di cui esso si servirà per costruire la società socialista. Sappiamo che questa lotta di classe dovrà diventare sempre più ampia e intensa, che il proletariato cresce sempre di più in numero e forza morale ed economica, che perciò la sua vittoria e la sconfitta del capitalismo sono inevitabili, ma possiamo fare soltanto delle ipotesi vaghe sul quando e sul come saranno combattute le ultime decisive battaglie di questa guerra sociale». La visione di Kautsky sembrava alternativa, nel senso che riteneva che la nuova società socialista sarebbe giunta inevitabilmente, si sarebbe manifestata attraverso un processo inconfutabile della storia. Infatti, si è soliti parlare della filosofia del leader della Socialdemocrazia tedesca come di un darwinismo sociale. La socialdemocrazia, quindi, si distingueva dal socialismo rivoluzionario (ad esempio, quello di Lenin o Rosa Luxemburg), solo in quanto ne congelava, per necessità storica e politica e non per convinzione, lo spirito di negazione totale del sistema. Tanto che, così come si opponeva ai movimenti rivoluzionari tout court essa contrastava, con altrettanta veemenza il riformismo. Essa non voleva affatto la sopravvivenza del sistema capitalistico e intendeva perpetuare lo spirito rivoluzionario e millenaristico, in attesa che i tempi fossero maturi per consentire il mutamento radicale della società in senso socialista. In poche parole, anche la socialdemocrazia restava legate alla rivoluzione palingenetica e allo spirito pantoclastico. Le attuali formazioni politiche che si definiscono socialdemocratiche hanno stipulato quello che si è soliti definire «il compromesso socialdemocratico» fra Stato e mercato. L’atto di nascita di tale trasformazione, che può essere considerata come una vera e propria mutazione genetica del movimento socialista, è datato, 15 novembre 1959, quando fu approvato il programma di Bad Godesberg, nome preso dalla località in cui si svolsero i lavori. Il programma fu redatto dal partito socialdemocratico tedesco; qui «il marxismo veniva messo in soffitta» e si affermava la necessità della «libertà di mercato e concorrenza per quanto possibile, pianificazione per quanto necessario». Revisionismo Per quanto riguarda il revisionismo storico, esso è una corrente che si definisce unicamente in rapporto al marxismo. Il suo fondatore e, insieme, rappresentante più illustre è stato Eduar Bernstein, che espresse le sue teorie nell’opera: I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia. Egli muove proprio dalla confutazione di alcune previsioni marxiane, smentite dagli avvenimenti storici. Sottoponendo il marxismo a una critica radicale, Bernstein smentiva la teoria del crollo del capitalismo per effetto della pauperizzazione crescente e della progressiva polarizzazione delle classi, visto, che, in realtà, osservando i fatti, la proprietà si diffondeva e i ceti medi aumentavano. Dunque, la dinamica storica dello sviluppo sociale non procedeva affatto come era stato previsto dalle «bronzee leggi della storia», individuate da Marx. «La socialdemocrazia – si legge nella sua opera – invece di speculare sul crollo finale, ha, ancora per lungo tempo, il compito di organizzare politicamente la classe operaia e lottare per tutte le riforme all’interno dello Stato che siano atte a trasformare la sostanza dello Stato in senso democratico». «Se da una classe – ammoniva Bernstein – la cui grande maggioranza è miseramente alloggiata, male istruita, guadagna poco, e quel poco che guadagna non è sicuro, noi non possiamo pretendere quell’alto livello intellettuale e morale che è il presupposto dell’instaurazione di una società stabile, cerchiamo allora di non attribuirglielo nemmeno» In sostanza, il socialismo, secondo il revisionismo storico, doveva diventare un «liberalismo organizzatore», ossia aprirsi ai valori della libertà individuale.
SALVEMINI
Per molti, visto che si tratta del filone interpretativo di numerosi studiosi, «il socialismo di Salvemini appartiene alla prima innocenza delle cose, quando ancora gli faceva difetto la consapevolezza piena e intera di se stesso; come un’effusione», o «scapricciamento giovanile e niente più». Un punto di partenza sicuro per comprendere se si può parlare di un Salvemini socialista e, soprattutto, a quale filone della grande famiglia socialista sia appartenuto, è comprendere il suo rapporto con il socialismo di Marx. In sostanza, egli non si può assolutamente ritenere un socialista marxista, anche «per la sua scoperta, fin troppo compiaciuta, refrattarietà agli svolazzi di idee che con l’essere filate e rifilate allestivano reti oltremodo complicate per la concretezza semplice delle sue aspirazioni». «La mania ideologica – scrive Salvemini nel 1904 – è endemica nel nostro partito: nessun compagno oserebbe muovere un passo, se non si fosse prima assicurato il viatico di una teoria astratta, che giustificasse per tutta l’eternità la sua azione». Se, però, è vero che, da una parte, non si perdeva dietro alle astratte idee del socialismo marxiano, dall’altra, deriva dalla concezione materialistica della storia, sicuramente il concetto di lotta di classe. «La classe lavoratrice – egli sostiene – deve conquistarsi da sé, con le sue forze, i suoi diritti; deve essere, stretta nelle proprie organizzazioni, attraverso le proprie esperienze, i propri errori, i propri dolori, l’artefice libera del proprio destino». Ancora, a Firenze nel 1908, dichiara che la lotta di classe è «tutto il socialismo». Il metodo principale, che può permettere l’emancipazione dei lavoratori, è quello della lotta di classe. Ma si tratta della stessa lotta di classe teorizzata da Marx e messa in pratica, ad esempio, da Lenin o da Mao? Cerchiamo di rispondere a questa domanda, attraversando la vita e gli scritti del nostro autore. Tra il 1910 e il 1920, egli abbandona il partito e fonda «L’Unità», un settimanale, che «nei suoi programmi doveva promuovere la democrazia». La democrazia «si esaurisce – scrive Salvemini – nel fine che debbono proporsi i democratici nella loro azione politica, cioè abilitare il maggior numero possibile di uomini a conquistarsi con lo sforzo consapevole e libero della propria volontà, la giustizia, il diritto, cioè il frutto intero del proprio lavoro, contro ogni forma di sfruttamento e di oppressione». Detta in questi termini sembra quasi che la «democrazia fosse né più né meno che la duplicazione terminologica del socialismo». Insomma, «tutti i motivi del suo socialismo trapassano nell’idealità della democrazia senza lasciarsi fermare da interposizioni o confini di sorta». È vero, certamente, che il Nostro «corre su una linea diritta dove passa dalla lotta di classe agli ideali della democrazia senza urti e senza stridori». «Il nostro giornale – si legge in un editoriale del 1914 – si rivolge ai giovani che hanno ideali democratici – […] senza fare questioni di metodi […]. Del metodo, il nostro giornale non si occupa». Da tale editoriale, traspare una sorta di indifferenza nei confronti del metodo, quasi come se la lotta armata o il dialogo parlamentare fossero la stessa cosa. Vi è da sottolineare, a questo punto, che egli stima il complesso delle istituzioni parlamentari come la forma «non solo più normale, ma anche la più utile perché la meglio adatta ai fini» della democrazia. Ai tempi dell’Unità, Salvemini lega le finalità della democrazia alle tecniche parlamentari ma «lo fa col filo esile, abbastanza scadente come tessuto, dell’opportunità politica, della convenienza pratica, della normalità statistica»; diverso, invece, è il suo atteggiamento in Memorie e soliloqui dove «si fa assai meno disponibile, e comunque ancora più inaccessibile ai metodi rivoluzionari». «I quali – si continua a leggere in Socialismo come libertà di Gaetano Pecora – per tenere gli uomini sospesi in una continua agitazione, per mantenerli in continuo ribollimento, alla fine riescono soltanto a fiaccarne la fibra e ad allentarne le molle vitali». Infatti, nelle Lezioni di Harvard, redatte nel 1943, possiamo leggere: «i socialisti rivoluzionari, che erano in maggioranza nelle organizzazioni politiche e nell’esecutivo nazionale del partito, cominciarono nel 1918 a chiamarsi massimalisti […]. Gli scioperi politici ed economici, sia locali che generali, erano salutati dai massimalisti quasi senza eccezioni come manifestazioni di spirito rivoluzionario; non si rendevano conto che in questi scioperi troppo ripetuti la classe operaia non rafforzava le proprie forze, ma al contrario le esauriva, e che da ultimo se ne sarebbe stancata, respingendoli come futili e dannosi». Nonostante queste parole risalgono al 1943, nel suo diario sotto la data 28 gennaio 1923, Salvemini scrive: «le “istituzioni” democratiche sono una parte degli “ideali democratici”, in quanto il mezzo necessario a raggiungere il fine ideale fa parte dell’ideale» medesimo. Con queste parole, egli «unisce così strettamente le istituzioni democratico-parlamentari con il fine del riscatto proletario, salda così tenacemente con questo fine quei mezzi e non altri, li salda così tenacemente con questo fine da concludere che le idealità perdute o tradite sempre e dovunque le si promuova con strumenti altri, differenti». Dunque, a quali condizioni la lotta di classe è realmente strumento di riscatto e di emancipazione? Solo e soltanto se i lavoratori saranno lasciati liberi di sbagliare, così da imparare dai propri errori. Ecco il gancio, con il quale Salvemini lega e salda la lotta di classe nelle istituzioni della moderna democrazia. La lotta di classe, qui, non è intesa in senso marxiano, come un movimento che risulta dallo scontro dialettico tra forze produttive e modi di produzione, non è necessario che il proletariato, intesa come classe eletta in senso religioso, acquisisca coscienza di sé e per sé, che si faccia braccio armato di una dottrina filosofica, che ha conosciuto e dato agli uomini, in senso quasi prometeico, le «bronzee leggi della storia». Anzi è proprio, il contrario. «La fede nella democrazia – scrive Salvemini – rampolla dalla persuasione ottimista che l’uomo impara a furia di prove ed errori, e se non comincia a provare e ad errare non imparerà mai». Le prove e gli errori degli uomini acquistano una valenza importantissima, fondamentale per la riuscita di un sistema democratico, a patto però «che le prove siano sempre e soltanto le loro prove; gli errori, solo ed unicamente i loro errori. Diversamente non si ravvederanno mai». «Donde l’esigenza – conclude il Prof. Pecora – che gli ideali democratici si sviluppino sui ritrovati giuridici della tradizione liberale, e precisamente su quei diritti personali e civili che sottraggono i singoli allo Stato-tutore e li proteggono dall’incontinenza della sua legislazione. In questo senso i diritti personali e civili sono la premessa necessaria della democrazia». A questo punto, se vogliamo attribuire a Salvemini il prisma del socialismo, bisogna capire di quale socialismo si tratta. Il prof. Pecora spiega: «il socialismo di Salvemini, sia pure adattato alle condizioni italiane, era lo stesso socialismo affermatosi con la socialdemocrazia della Seconda Internazionale». Infatti, egli prendeva proprio dalla Seconda Internazionale: l’opzione riformista «e quindi l’idea che la lotta di classe dovesse rifluire nell’alveo degli istituti parlamentari»; oppure l’idea che gli strumenti democratici fossero plausibili per il perseguimento di qualsiasi fine; soprattutto, però, derivava dalla socialdemocrazia tedesca un certa concezione della storia, «che incastonava le vicende umane in tappe successive, evolventesi le une dalle altre, per cui ci sarebbe stato un prima (capitalismo) e un dopo (il socialismo), con il primo che faceva da antecedente necessario del dopo, e il dopo che non si sarebbe mai prodotto senza un prima, quel prima». Quindi, è bene rilevarlo e ripeterlo, socialismo sì, ma esso non nascerà dal nulla o da un atto violento, quale può essere una rivoluzione; piuttosto sarà qualcosa «che si produce progressivamente, per accumulo di riforme». Ma davvero possiamo annoverare Salvemini socialdemocratico nel senso kautskyano del termine? Forse questa serie di citazione potrebbe aiutarci a capire meglio, in che modo si relazioni con la socialdemocrazia tedesca. Infatti, rivolgendosi al’esecutivo del Spd egli scrive: «Voi intendete lavorare a un rinnovamento sociale totale, cioè all’abolizione per opera della classe proletaria del regime capitalista. Nello stesso tempo, se non mi inganno, voi riconoscete che la lotta per quel rinnovamento deve essere condotta da uomini liberi col metodo della libertà». Ancora «io non vedo perché la politica diretta a promuovere una trasformazione totale attraverso un processo graduale debba essere chiamata “rivoluzionaria”. Questa parola “rivoluzione” può avere due significati. Può significare un rinnovamento totale, senza alcuna idea di violenza catastrofica e […] può significare uno sconvolgimento sociale o politico violento dovuto a forze extralegali». «Se affermandovi – concludeva – assertori di una politica rivoluzionaria voi intendete dire che aspirate ad un rinnovamento totale, voi non avete nessun bisogno di chiamarvi rivoluzionari. Dovrebbe bastare di chiamarsi socialisti». E se queste non fossero bastate, per comprendere le distanze tra Salvemini e il metodo rivoluzionario, che intende soppiantare le libertà individuali e le istituzioni parlamentari, ecco una bellissima lettera, scritta a un’amica torinese. «Io ho raggiunto 82 anni; da sessant’anni sento parlare di rivoluzione; ma una rivoluzione non l’ho mai vista. Invece ho visto una evoluzione: lenta frammentaria, continuamente interrotta, eppure visibile. C’è oggi in Italia meno miseria che nel 1890, quando io avevo diciassette anni. Vi sono oggi diritti della classe lavoratrice, che allora nessuno si sognava neanche di chiedere, anche se era socialista rivoluzionario. Queste conquiste sono state l’opera di persone come Lei e – se mi consente aggiungere – come me che abbiamo sofferto all’idea di coloro che stavano peggio di noi. Nel 1947, quando tornai dall’America dopo 22 anni di assenza, mi misi a conversare con una donna di servizio, intelligentissima e squisitamente buona. Lei mi disse che era sempre stata socialista e aveva sessant’anni. Le domandai: «Perché sei sempre stata socialista?». Mi rispose: «Perché penso che ci deve essere un po’ di bene per tutti». Questo, cara amica, è il socialismo». Si passa dal rinnovamento totale a un «po’ di bene per tutti», ossia si passa da due opposte tipologie di riformismi: l’uno quello dei mezzi, l’altro quello dei fini.
Secondo il riformismo dei fini: «l’ordine esistente, in linea di principio, va accettato in toto, non solo la democrazia liberale, ma anche l’assetto economico detto capitalistico, allo scopo di migliorarlo, rendendolo più giusto e dunque più forte. Il riformismo dei mezzi, invece, non crede realizzabile o opportuno l’uso della violenza, e ritiene che si debba arrivare al collettivismo, alla trasformazione radicale della società esistente, attraverso le riforme».