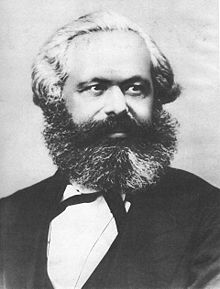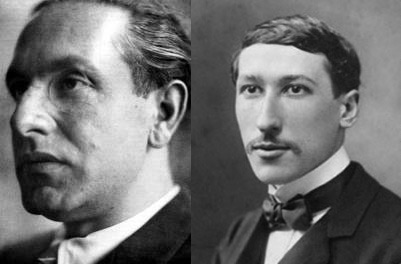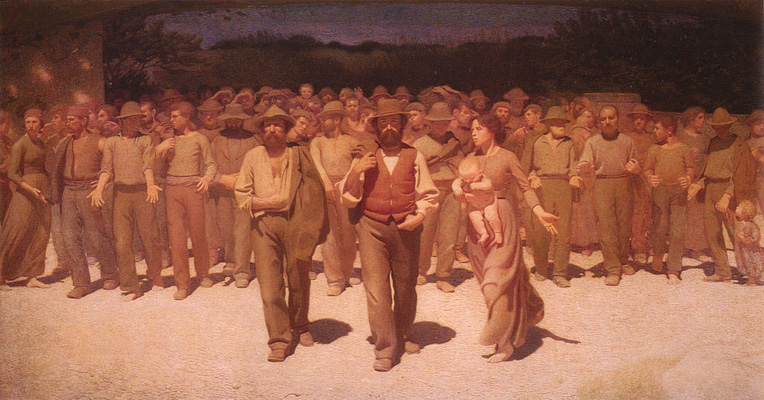Considerazioni finali sulla tolleranza e le libertà
E’ dunque falso sostenere che il liberalismo – il liberalismo come atteggiamento morale – autorizzi gli uomini a perseguire esclusivamente i propri interessi a danno degli altri membri della società, stimolando così l’opportunismo egoistico e cinico di chi è privo della speranza di un’idea, della guida di una convinzione per un futuro più equo per tutti. << Sarei profondamente afflitto – scriveva Gaetano Salvemini – se (…) qualcuno dei miei lettori dovesse giungere alla conclusione che essi debbono essere indifferenti di fronte alla questione della verità o dell’errore, del bene e del male>>. Non bisogna mai sottrarsi, mai restare muti di fronte alle domande di giustizia e di libertà che ogni uomo reclama. Ma le risposte elaborate dalla dottrina liberale non hanno la presunzione di essere le uniche verità assolute ed inconfutabili. Le risposte liberali sono ipotesi e non dogmi. Il liberalismo rifiuta ogni forma di dogmatismo. Ma << rifiutare il dogmatismo non equivale a non credere. – avverte, giustamente, Giovanni Sartori – La fede nella libertà è una fede. La differenza è che è una fede che non ammazza, perché è una fede che impone di rispettare la libertà di fede dell’altro >>. Una fede che non ammazza, che dialoga, che tollera la fede dell’altro. Le fedi, se vissute in modo non dogmatico, possono convivere e confrontarsi secondo regole prestabilite e condivise senza far ricorso alla violenza. In questo senso il principio della tolleranza reciproca, non deriva esclusivamente dal relativismo culturale, è, prima di ogni cosa, un dovere giuridico, e non necessariamente un dovere intellettuale o morale. << Rispettare il principio giuridico della tolleranza – avverte Salvemini – non significa cedere di fronte a coloro che la pensano diversamente da noi, né essere pronti a cambiare le nostre opinioni come banderuole al vento. Noi e i nostri oppositori abbiamo lo stesso diritto di sostenere le nostre opinioni e lo stesso dovere di rispettare negli altri quel diritto. Ma non abbiamo alcun obbligo di essere intellettualmente tolleranti dei loro errori o moralmente tolleranti dei loro misfatti.
Se vogliamo conservare il rispetto di noi stessi è nostro diritto intellettuale e nostro dovere intellettuale di sostenere senza compromessi il nostro punto di vista e di essere intellettualmente intolleranti dei loro errori finché essi non ci abbiano convinti con argomenti abbastanza forti che noi ci sbagliamo. Se essi dovessero riuscire a convincerci che ci sbagliamo, dobbiamo diventare intellettualmente o moralmente intolleranti del nostro errore ed eliminarlo istantaneamente >>.
La tolleranza consente, dunque, il libero confronto e la concorrenza fra le diverse idee – intorno ad un preciso argomento, che costituisce l’oggetto della disputa – in una cornice istituzionale condivisa dagli attori sociali. Una cornice istituzionale che può assumere una dimensione nazionale o internazionale. Di qui l’istituzionalizzazione del dissenso, vero e proprio architrave delle democrazie liberali. Infatti dal libero dissenso derivano una lunga serie di diritti. Il diritto alla libertà di parola, di stampa, di associazione. Il dissenso, dunque, anticipa le libertà politiche. Queste, a loro volta, implicano il diritto di rappresentanza delle opposizioni, e il diritto delle opposizioni rende sicure le libertà individuali. In questo senso si dice che le libertà liberali sono solidali tra di loro. Quindi, istituti rappresentativi, libertà politiche e diritti personali nascono dal libero dissenso. Il libero dissenso, a sua volta, è il << precipitato giuridico >> del valore tolleranza.
Alla luce di tutto quello che si è detto finora, il modo migliore per concludere questa sintetica descrizione delle basi culturali della dottrina liberale è quello di ripetere le parole pronunciate da Hans Kelsen a conclusione della sua ultima lezione universitaria: << non so né posso dire che cosa è la giustizia, quella giustizia assoluta di cui l’umanità va in cerca. Devo accontentarmi di una giustizia relativa e posso soltanto dire cosa è per me la giustizia. Poiché la scienza è la mia professione, e quindi la cosa più importante della mia vita, la giustizia per me è quell’ordinamento sociale sotto la cui protezione può prosperare la ricerca della verità. La mia giustizia è la giustizia della libertà, la giustizia della democrazia: in breve, la giustizia della tolleranza >>.
Ludovico Martello