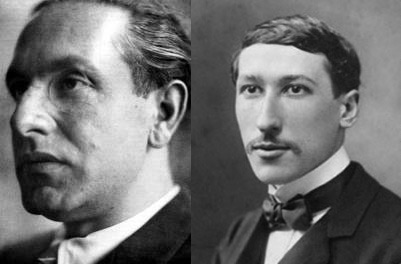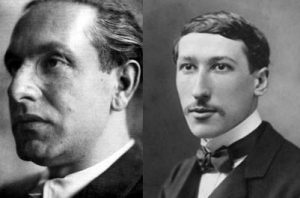
Come abbiamo già detto, il termine
socialismo può essere usato, per indicare anche teorie politiche poste, apparentemente, l’una distante dall’altra, come ad esempio il
socialismo marxista e il nazionalsocialismo
tedesco.
Al riguardo va subito detto che il
nazismo fu un movimento rivoluzionario nel senso più forte del termine, tanto che Theodor Heuss (13 gennaio 1884-12 dicembre 1963) scrive «se si cerca un denominatore comune della mentalità dei gruppi sociali o degli individui che aderiscono al partito di
Hitler, si può dire che questi sono associati da una mentalità aniticapitalistica»
[1]. In effetti, l’anticapitalismo degli attivisti del Nsdap è così radicale che i famosi Venticinque Punti prevedono l’«eliminazione dei guadagni senza
lavoro e senza fatica», la «riforma fondiaria (…) e la creazione di una legge per l’esproprio senza risarcimento di terreni da adibire a fini utili per la comunità» e la «statalizzazione di tutte le imprese di carattere monopolistico»
[2].
Il radicalismo di tale programma è amplificato dalle stesse
parole di
Hitler, il quale affermava che «il nazionalsocialismo era il contrario di tutto ciò che esisteva» e che il partito nazionalsocialista dei lavoratori era un «partito rivoluzionario» il cui obiettivo era l’«abolizione dello stato delle cose esistenti»
[3].
Già da queste poche
parole possiamo intravedere una sorta di simbiosi tra il partito nazionalsocialista
tedesco e i
partiti di ispirazione marxisti, tanto che lo stesso Joseph Goebbels (29 ottobre 1897-1 maggio 1945) arriva a confessare che considera «orribile seguitare a bastonarsi a quel modo con i comunisti». «Voi e io – scrive il Ministro della Propaganda del Terzo Reich – ci combattiamo a vicenda senza essere nemici, e in questo modo non arriveremo mai allo scopo. Forse l’ora del pericolo ci unirà. Forse!»
[4]; e infine, «Il futuro è la dittatura dell’idea
socialista nello Stato».
Lo stesso
Hitler afferma: «io non sono soltanto il vincitore del marxismo, ma anche il suo realizzatore: ossia di quella parte di esso che è essenziale e giustificata, spogliata del suo dogma ebraico-talmudico (…). Il nazionalsocialismo è ciò che il marxismo avrebbe potuto essere se fosse riuscito a spezzare i suoi legami assurdi e superficiali con un ordine democratico: (…) una dottrina di redenzione, basata sulla scienza, che possiede tutti i requisiti per conquistare il
potere»
[5]Resta il fatto, però, che negli anni immediatamente alla Machtergreifung la
politica economica del partito nazista non resta fedele alla sua vocazione anticapitalistica. Al contrario essa si attiene a un criterio che lo stesso
Hitler formula in questi termini: «In linea di massimo il
Governo non eserciterà la cura degli interessi economici del popolo
tedesco attraverso l’interposizione di una burocrazia economica organizzata stabilmente, bensì mediante il più energico incoraggiamento dell’iniziativa privata e nel riconoscimento della proprietà privata»
[6]. In realtà, sia
nazismo che
fascismo, seppur in contraddizione con le loro idee più radicali ma coerenti con il messaggio iniziale, appena si impadroniscono del
potere non sostituiscono l’
economia di mercato con l’
economia di Stato, poiché da tempo giungono alla conclusione che quest’ultima, così come descritta dai
partiti d’ispirazione marxista, avrebbe portato al collasso la produzione. La
destra totalitaria realizza quel fenomeno che Ernst Fraenkel chiama Dopplestaat, ossia «una singolare combinazione di assenza totale di garanzie giuridiche nella sfera
politica culturale e di piena vigenza delle stesse nella sfera economica»
[7]. Ovviamente, tutto ciò non impedisce al Terzo Reich di sottoporre «a rilevanti limitazioni (…) il
diritto di disporre liberamente della proprietà e degli interessi del capitale» e di «condurre una
politica interventista particolarmente intensa», eliminando «ogni iniziativa, ogni facoltà di decidere e di scegliere»
[8].
Molto si è discusso sull’istituzionalizzazione del Doppio Stato, tanto che copiosa letteratura marxista sostiene che i fascismi abbiano sostenuto l’ideale capitalistico. Simili letture, però, sembrano essere insostenibili, poiché dimenticano un fatto di fondamentale importanza, cioè che «la rivoluzione fascista si considerò una Terza Forza, rifiutante sia il marxismo materialista che il
capitalismo finanziario, in un’epoca materialista e finanziaria»
[9]. Tutta la cultura
politica della
destra radicale è una violenta reazione contro «la società borghese e il suo modus vivendi»
[10]. Infatti, non un solo valore o istituzione del
mondo moderno è risparmiato dagli attacchi degli ideologi attivi della rivoluzione fascista.
Uno su tutti è sicuramente Julius Evola (19 maggio 1898-11 giugno 1974), il quale sostiene che «la società contemporanea si presenta appunto come un organismo che dal tipo umano è passato a quello subumano, nel quale ogni attività e ogni reazione è determinata dai bisogni e dalle tendenze della pura
vita fisica. I suoi principi dominanti sono esattamente quelli propri alla parte
fisica delle gerarchie tradizionali: l’oro e il
lavoro. Così si sono orientate le cose, che questi due elementi vanno oggi a condizionare quasi senza eccezione ogni possibilità di esistenza e a forgiare ideologie e miti, dai quali non saprebbe risultare più chiara la gravità del moderno pervertimento di tutti i valori»
[11]L’aristocratico italiano rimpiange i secoli oscuri del Medioevo e definisce il momento storico che l’
umanità sta vivendo con il termine antico indù: «Kalì-Yuga», che significa appunto «età oscura». Infatti, «è corrispondente per questa era la teoria del contratto sociale: come legame sociale – scrive Evola – ora non si trova più nemmeno una fides di tipo guerriero, cioè rapporti di fedeltà e onore. Il legame sociale assume un carattere utilitario e economico: è un accordo in base alla convenienza e all’interesse materiale – quello, che solo un mercante può concepire. L’oro fa da tramite e chi se ne impadronisce e sa moltiplicarlo (
capitalismo, finanza, trust industriali) dietro la facciata democratica controlla virtualmente anche il
potere politico e gli strumenti di formazione della pubblica opinione»
[12]. Non sembrano molto diverse le
parole di Marx, il quale descrive il denaro come «l’universale confusione e inversione di tutte le cose, e quindi il
mondo rovesciato, la confusione e inversione di tutte le qualità umane e naturali»
[13] . Per questi motivi, da tradizionalista radicale qual è, Evola giunge, persino, a dire che «se intesa come una rivolta contro la tirannide economica, contro lo stato di cose in cui non l’individuo ma la quantità d’oro, il capitale, comanda; in cui la preoccupazione per le condizioni materiali dell’esistenza, assorbe tutta l’esistenza; se intesa come ricerca di un equilibrio economico, sulla base del quale abbiano modo di liberarsi e di svilupparsi forme diverse di
vita non più riducibili al piano materiale, se intesa a questa stregua, ma a questa soltanto, potremmo riconoscere persino nel
socialismo e nello stesso
comunismo un funzione necessaria e un avvenire»
[14].
Dunque, entrambi i movimenti socialisti (quello marxista e quello nazionalsocialista) attaccano il
mondo moderno, i suoi valori e le sue istituzioni, considerano il mercato e la borghesia come il peggiore dei mali ma essi si differenziano per il soggetto, che incarna il Male. Se per Marx il Male è rappresentato dal
capitalismo,che si identifica con i capitalisti, poiché detentori dei mezzi di produzione; per i nazisti il sistema economico capitalistico è opera del «giudaismo onnipotente».
È importante osservare che anche lo stesso Marx, nonostante le sue
radici, sia critico verso il giudaismo. «Qual è il principio mondano dell’
ebraismo? L’esigenza pratica, il proprio vantaggio. Quel è il suo
dio terrestre? Il danaro». «L’Ebreo si è emancipato in modo ebraico non solo in quanto si è appropriato della potenza del denaro, ma anche in quanto per suo mezzo il danaro è divenuto potenza mondiale e lo
spirito praticistico ebraico è divenuto lo
spirito praticistico dei popoli cristiani. Gli
Ebrei si sono emancipati in quanto i Cristiani sono divenuti degli
Ebrei. Il
dio degli
ebrei si è mondanizzato ed è divenuto
dio della terra. Il cambio è il vero
dio degli
ebrei»
[15].
Entrambi i movimenti, dunque, rivelano nel
capitalismo, volendo usare un espressione di Werner Sombart (19 gennaio 1863-18 maggio 1941) lo «
spirito giudaico distillato».
La differenza sostanziale che corre tra il marxismo e il
nazismo, è dovuta al fatto che i primi attaccano gli
ebrei, non perché esponenti di una razza, ma perché capitalisti e quindi appartenenti a una classe determinata; i secondi, invece, ritengono gli
ebrei dei «nemici esterni», intenti «a trasformare la Germania in una nazione con fondamento e
spirito ad essa estranei»
[16]In definitiva, alla Weltanschauung marxista, centrata sulla guerra mortale fra le classi,
Hitler contrappone una Weltanschauung centrata sulla guerra mortale fra le razze. Ma la posta in palio resta la stessa: il destino dell’
umanità.
Così il giudaismo, come la classe borghese per Marx, diviene un principio metafisico e come il proletariato rappresenta la classe eletta che deve guidare l’
umanità verso il
comunismo,
Hitler diviene «il Redentore del Volk»
[17] e la «la verità in persona»
[18].
È facile intuire la sottile linea rossa che collega movimenti, così apparentemente antitetici come il
comunismo bolscevico e il nazionalsocialismo
tedesco.
Ma se dovessero esserci ancora dubbi al riguardo, basta comparare ciò che scrivono Lenin nel Che fare? e
Hitler nel Mein Kampf.
«Piccolo gruppo compatto – scrive Lenin – noi camminiamo per una strada ripida e difficile con forza per mano. Siamo da ogni parte circondati da nemici e dobbiamo quasi sempre marciare sotto il fuoco. Ci siamo uniti, in virtù di una decisione liberamente presa, allo scopo di combattere i nostri nemici e di non sdrucciolare nel vicino pantano, i cui abitanti, fin dal primo momento, ci hanno biasimato per aver costituito un gruppo a parte e preferito la via della lotta alla via della conciliazione (…). Del resto, pensiamo che il vostro posto è proprio nel pantano e siamo pronti a darvi il nostro aiuto per trasportarvi i vostri penati»
[19]. Il compito del rivoluzionario bolscevico è quello di «ripulire di qualsiasi insetto nocivo la maledetta società capitalista»
[20] e del resto quale
diritto hanno di vivere esseri, che non sono
uomini, bensì immondi «parassiti»
[21], che vivono, simili a «vampiri»
[22].
L’ideale rivoluzionario del Führer non è, affatto, diverso. «La scoperta del
virus ebraico – dichiara alla fine del febbraio del 1942 – è una delle massime rivoluzioni che mai siano state compiute al
mondo. La lotta che noi conduciamo è dello stesso tipo di quella iniziata, nel secolo scorso, da Pasteur e Koch. Quante malattie non vanno attribuite al
virus giudaico! Recupereremo salute, soltanto a patto di sterminare l’ebreo»
[23]. Ancora, «io mi sono mostrato leale – afferma
Hitler in un discorso del 13 febbraio del 1945 – nei confronti degli
ebrei. Ho lanciato loro, alla vigilia della guerra, un ultimo avvertimento. Li ho avvertiti che, se avessero precipitato di nuovo il
mondo nella guerra non sarebbero stati questa volta risparmiati – e i parassiti sarebbero stati definitivamente sterminati in
Europa … Noi abbiamo fatto scoppiare l’ascesso giudaico così come gli altri. Le future generazioni ci saranno eternamente riconoscenti»
[24]. Si può facilmente notare come il lessico di Lenin sia molto simile a quello di
Hitler. La meta
finale del bolscevismo è la società senza classi e senza Stato, mentre il Reich nazionalsocialista divide l’
umanità in schiavi e signori.
Giustamente, Norman Cohn vede nel boscevismo e nel nazionalsocialismo «gli ultimi avatara del millenarismo giudaico-cristiano, annuncianti una salvezza insieme terrena e collettiva»
[25] e dominati dall’esigenza di «purificare il
mondo eliminando gli agenti della sua
corruzione»
[26].
Dunque, il nazionalsocialismo, come il bolscevismo, è un movimento gnostico di massa, animato da fantasie apocalittiche e pantoclastiche. E proprio come nella
Russia comunista e per le stesse ragioni di principio, una Gnosi apocalittica, ex definitione, nella Germania nazista non vi è posto per una
religione alternativa a quella dello Stato-Partito, il quale rivendica «nel campo dell’opinione pubblica lo stesso posto che occupava la
Chiesa Romana nel campo della fede»
[27]; insomma nasce «una nuova
religione, le cui
radici, al pari di quelle di ogni
religione e fede, non si limitavano a penetrare nel subconscio, ma si spingevano più a fondo, fino a divenire tutto un modo di esistere»
[28]Prima di parlare nel dettaglio della nuova
destra è preferibile ricordare le caratteristiche dell’organicismo.
L’organicismo è una dottrina filosofica secondo la quale il tutto viene prima delle parti sia cronologicamente che assiologicamente. Le caratteristiche principali dell’organicismo, quindi, sono: «a) la comunità viene prima dei singoli, e il valore delle parti si misura in ragione dei vantaggi del tutto; b) questo tutto non conosce attriti frizioni o dissapori di sorta. Non ci sono voci dissonanti: è un tutto armonico dove ciascuno nel
rispetto del suo spartito, canta sempre nello stesso coro; c) come in ogni coro, anche qui c’è un direttore che scandisce il ritmo e dirige la musica»
[29].
Fatta questa premessa, possiamo dire che quando i
sostenitori della nuova
destra si rivolgono al senso e alla funzione della comunità essi non fanno altro che richiamare le teorie di Rousseau. Essa, insomma, viene definita «nuova» perché rinuncia alle implicazioni autocratiche ma ha la
democrazia degli antichi come referente ideale, non quella dei moderni. Gli esponenti della nuova
destra si reputano sì democratici ma di una
democrazia diversa da quelle moderne.
È necessario comprendere, preliminarmente, che la
democrazia è una «crazia», ossia un
potere mentre il
liberalismo è una tecnica di limitazione del
potere. Il
potere non è limitato solo quando chi lo esercita è vincolato al
rispetto di determinate procedure (limitazione formale) ma anche quando «agli imperativi di chi comanda viene sottratta una serie di comportamenti che non possono essere né comandati né proibiti, e che non potendo essere né comandati né proibiti vanno consegnati alla libera, insindacabile discrezionalità dei singoli»
[30]; questa è quella che si definisce la limitazione materiale.
Dunque, le limitazioni materiali e formali sono i due pilastri dello Stato liberaldemocratico, e poiché la
democrazia moderna si innesta sulle strutture di un ordinamento così fatto, ne segue che essa non può prescindere dai dispositivi giuridici del costituzionalismo
liberale.
I
sostenitori della nuova
destra, che trovano in Alain de Benoist, il loro maggior rappresentante, sconfessano le regole costituzionali e i meccanismi giuridici che imbrigliano la potestà popolare; essi assurgono a
sostenitori di quella che possiamo definire la
democrazia pura, pura proprio perché non contaminata dal
liberalismo.
Secondo de Benoist, «non è l’idea del
potere assoluto che la
democrazia respinge, ma l’idea che simile
potere sia
privilegio di una sola persona»
[31]. Così la Costituzione è ridotta a documento «vago e poco durevole»
[32], e il filosofo rimprovera ai costituzionalisti una concezione feticistica delle legge, perché risolvono la
democrazia in un insieme di procedure e limiti giuridici. De Benoist, quindi, fonda la
democrazia non sul dominio impersonale della legge, ma sull’assoluto
governo dei cittadini. Ma chi sono i cittadini?
I cittadini – secondo de Benoist – sono coloro che discendono dalla stessa stirpe e che partecipano alla medesima cultura. Per il fatto di avere origini e valori in comune essi, e ad essi soli sono investiti di eguali diritti politici; questi si compendiano nella facoltà di partecipare alla formazione delle decisioni collettive e in tale partecipazione si riassume la loro
libertà.
Libertà come partecipazione, uguaglianza
politica e cittadinanza risultano così indissolubilmente legate; sono gli anelli di una catena che inizia dall’esistenza di una comunità organica spiritualmente compatta e omogenea.
E poi, egli conclude, sferrando l’ennesimo attacco, e ormai ripetitivo ai valori dell’individualismo, affermando che bisogna «tornare ad una concezione greca della democrazia»il che «non significa accarezzare la
speranza, costantemente delusa, di una trasparenza sociale da “faccia a faccia”. Significa riappropriarsi, per adattarla al
mondo moderno, di una concezione del popolo e della comunità oscurata da duemila anni di (…) esaltazione dell’individuo senza appartenenze»
[33].
L’avversario è sempre lo stesso il
liberalismo e i diritti individuali. Infatti, Marco Tarchi sostiene che gli esponenti della nuova
destra «accettano appieno le regole del gioco democratico – in primo luogo quelle della legittimazione
politica basata sul consenso e sul controllo popolare sugli atti del
governo – ma non accettano affatto l’ideologia
liberale»
[34] .
Tutto ciò «è sbagliato perché le regole democratiche muovono dalle premesse dell’individualismo
liberale e dunque non sono assiologicamente neutrali come gli ingranaggi di un meccanismo senza anima»
[35]. Se si eliminano le
libertà individuali e i valori che porta con se l’individualismo il primo limite al
potere assoluto viene meno, cade definitivamente il dissenso: «o l’individualismo con il corteggio del dissenso e delle altre regole della democrazia, o l’organicismo senza dissenso e senza democrazia (senza questa democrazia)»
[36].
La nuova
destra, diversamente dai
partiti e dagli ideologi marxisti, seppure disprezzano l’individualismo e l’atomismo sociale non riservano nessuna delle loro critiche all’
economia di mercato. Tralasciano completamente che il mercato e lo
spirito imprenditoriale è stata una delle forze che nei secoli hanno contribuito a secolarizzare il
mondo a rodere terreno allo spirituale, al sacro e al trascendente e, di conseguenze, al gruppo sociale monolitico e immutabile.
Entrambi – marxisti e radicali di
destra – avversano l’egoismo e aspirano ad una comunità pacificata ma mentre i primi demonizzano il mercato, propugnando la statizzazione dell’
economia, i secondi detestano tale soluzione e teorizzano un riordinamento corporativo della società, assegnando ai gruppi professionali il ruolo che oggi svolgono i singoli imprenditori. Ma de Benoist e gli altri dimenticano che anche «sull’egoismo e sugli interessi materiali si fondano le corporazioni»
[37]e che fra esse «esiste, per natura, non una comunione ma un conflitto di interessi»
[38].
In definitiva, le idee della nuova destra sono poco praticabili sia per l’estensione del territorio e perché si scontra, violentemente, con l’idea di mercato, facendo della democrazia organica un’utopia, l’ennesima illusione che cerca di riportare l’uomo alle antiche forme comunitarie di matrice spartana.
A tal proposito Benjamin Costant scrive che nel momento in cui certe istituzioni si sono affermate «presentavano una qualche utilità è una bontà relativa, in quanto erano proporzionate allo stato delle conoscenze e delle abitudini»; aggiunge che «man mano che lo spirito umano ha progredito, questi vantaggi sono diminuiti e le istituzioni si sono allora modificate». Infine, ammonisce che «volerle ristabilire nella loro purezza primitiva sarebbe un grande errore perché questa purezza si troverebbe ad essere esattamente opposta alle idee contemporanee, e la più adatta a provocare del male»[39].
[1] Cit. da L. L. Rimbotti, Il mito al potere, Edizioni del Settimo Sigillo, Roma
1992, p. 213.
[2] Programma del Partito
tedesco dei lavoratori nazional-socialisti, in T. Buron e P. Gauchon, I fascismi, Akropolis,
Napoli 1984, p. 100.
[3] A.
Hitler, Mein Kampf, Gli Impubblicabili, Roma s.d., p. 104.
[4] Cit. da J. Fest, Il volto del Terzo Reich, Garzanti, Milano 1997, pp. 142-143.
[5] H. Rauschning, Così parlò Hitler, Cosmopolita, Roma 1944, p. 225.
[6] A. Hitler, Discorsi di guerra, Ronzon, Roma 1941, p. 223.
[7] L. Pellicani, La società dei giusti, p. 375.
[8] A. Aron, Machiavel et les tirannie modernes, Fallois, Paris 1993, p. 171.
[9] G. L. Mosse, Towards a General Theory of Fascism, in G. L. Mosse (a cura di) International Fascism, Sage, London 1979, p. 6.
[10] G. L. Mosse, L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste, Laterza, Bari 1970, p. 141.
[11] J. Evola, Rivolta contro il
mondo moderno, Edizione Mediterranee, Roma 2010, p. 372.
[13] K. Marx, Manoscritti economici-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 1968, a cura di Norberto Bobbio, p. 121.
[14] J. Evola, Imperialismo pagano, Edizioni Ar, Padova 1978, p. 108.
[15] K. Marx, Sulla questione ebraica, Bompiani, Milano 2007
[16] T. Mann, Considerazione di un impolitico, De Donato, Bari 1967, p. 137.
[17] L. Pellicani, La società dei giusti, cit. p. 385.
[18] J. Goebbels, Il Führer, in W. Hofer (a cura di), Il Nazionalsocialismo, p. 225.
[19] Lenin, Che fare?, cit. p. 327.
[23] A. Hitler, Il libro segreto, Loganesi, Milano 1962, p. 130
[24] A. Hitler, Ultimi discorsi, Edizioni Ar, Padova 1988, p. 52.
[25] L. Pellicani, La società dei giusti, cit. p. 371.
[26] N. Cohn, I fanatici dell’apocalisse, p. 377
[27] N. Frei, Lo stato nazista, Laterza, Bari
1992, p. 234.
[28] G. L. Mosse, Le origini culturali del Terzo Reich, Il Saggiatore, Milano 1968, p. 447.
[29] G. Pecora, La
libertà dei moderni, Luiss University Press – Pola S.r.l., Roma 2004, p. 35.
[31] A. de Benoist, Democrazia: il problema, Arnaud, Firenze 1985, p. 41.
[34] M. Tarchi, Quando Saint-Just fa il portaborse, in Diorama letterario, n. 115, maggio 1988, p. 9.
[38] H. Kelsen, La democrazia, Il Mulino, Bologna 1981, p. 89.
[39] B. Costant, Conquista e usurpazione, Einaudi, Torino 1983, pp. 147-157.
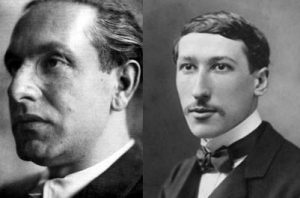 Come abbiamo già detto, il termine socialismo può essere usato, per indicare anche teorie politiche poste, apparentemente, l’una distante dall’altra, come ad esempio il socialismo marxista e il nazionalsocialismo tedesco.
Come abbiamo già detto, il termine socialismo può essere usato, per indicare anche teorie politiche poste, apparentemente, l’una distante dall’altra, come ad esempio il socialismo marxista e il nazionalsocialismo tedesco.